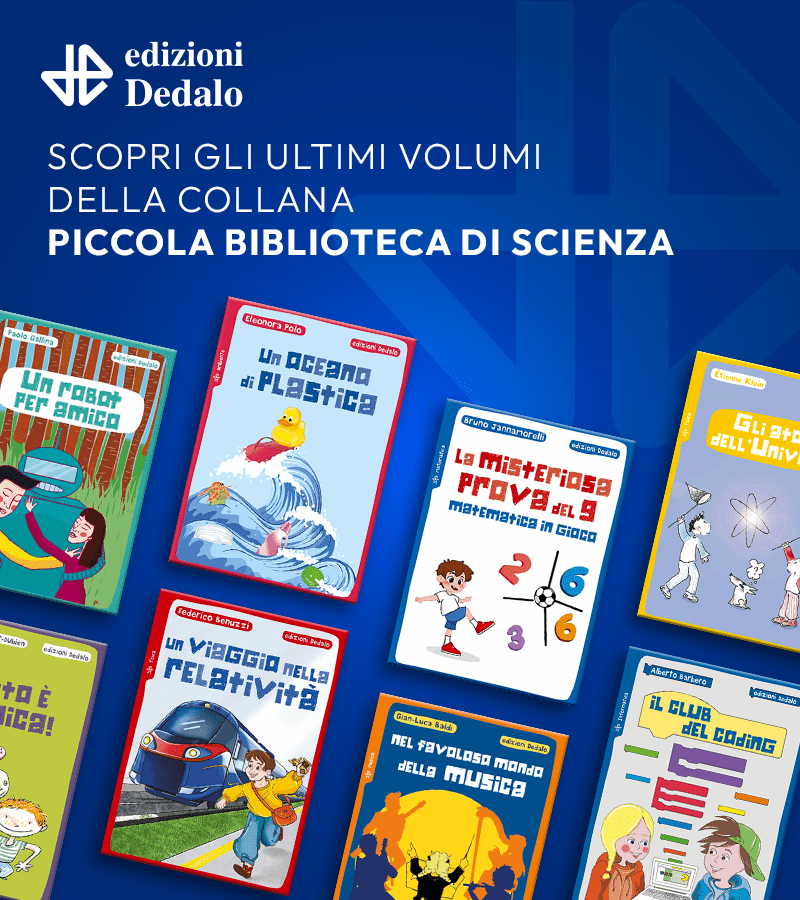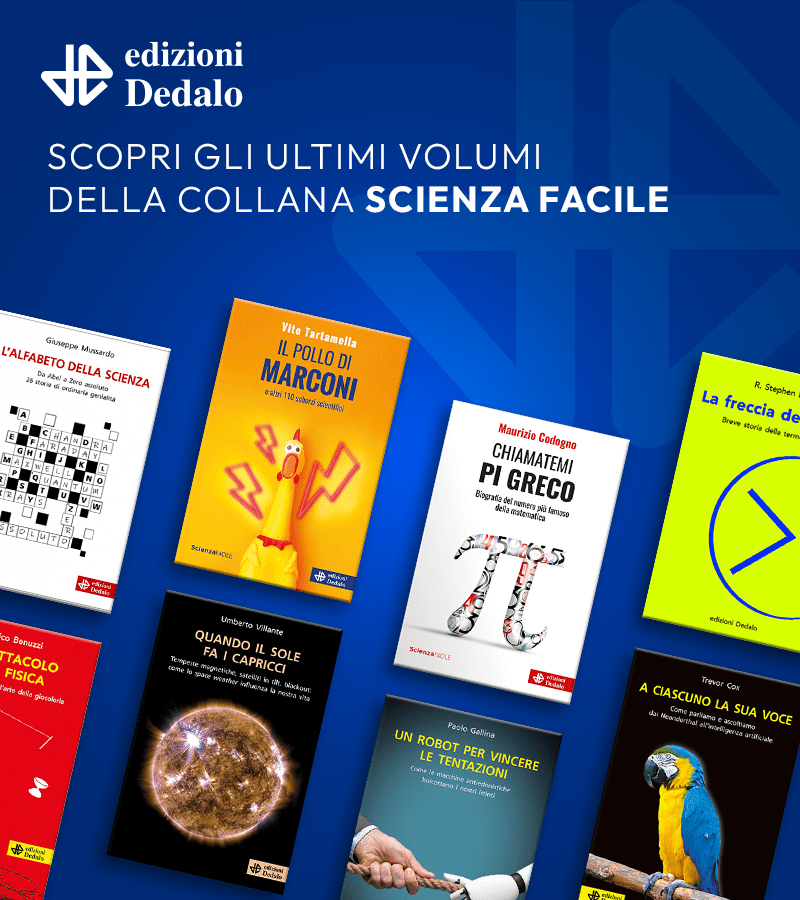Le condizioni della laguna di Venezia sono da molto tempo sotto la lente di ingrandimento dei media e soprattutto della scienza. Le opere umane, il traffico navale e l’inquinamento stanno mettendo a dura prova la salvaguardia di questo territorio. La comprensione dell’evoluzione del paesaggio e un monitoraggio accurato sono le prime risposte a un problema che sta divenendo sempre più incombente. Uno studio dell’Istituto di Scienze Marine del CNR, pubblicato recentemente sui Scientific Reports di Nature, ha descritto i risultati della valutazione dell’attività antropica sui fondali della laguna di Venezia, facendo emergere i due fattori di distruzione principali: l’erosione e la presenza di rifiuti.
Le condizioni della laguna di Venezia sono da molto tempo sotto la lente di ingrandimento dei media e soprattutto della scienza. Le opere umane, il traffico navale e l’inquinamento stanno mettendo a dura prova la salvaguardia di questo territorio. La comprensione dell’evoluzione del paesaggio e un monitoraggio accurato sono le prime risposte a un problema che sta divenendo sempre più incombente. Uno studio dell’Istituto di Scienze Marine del CNR, pubblicato recentemente sui Scientific Reports di Nature, ha descritto i risultati della valutazione dell’attività antropica sui fondali della laguna di Venezia, facendo emergere i due fattori di distruzione principali: l’erosione e la presenza di rifiuti.
Le mani dell’uomo sulla laguna
L’area veneziana è abitata e sfruttata da tempi lontani. Dall’epoca dei Romani al Medioevo l’isola all’interno della parte settentrionale della laguna è stata abitata; in seguito Venezia si è elevata a potenza europea, una delle città più grandi con una popolazione che, verso la fine del XIII secolo, contava 100.000 abitanti. Ora è uno dei centri nevralgici di arte e cultura nel mondo, intorno al quale gravitano 25 milioni di visitatori all’anno. Storicamente i veneziani sono sempre stati consapevoli della necessità di salvaguardare il territorio che occupavano, sapendo che la sopravvivenza della città era (ed è) in bilico sul sottile filo dell’equilibrio della laguna. È per questo motivo che l’azione dell’uomo ha influenzato in grande misura la sua evoluzione, da un punto di vista morfologico e di estensione.
Le attività umane hanno da sempre alterato l’ecosistema della regione con continue modifiche: la deviazione dei suoi maggiori affluenti (i fiumi Brenta e Piave) tra il XV e il XVII secolo, la costruzione di barriere per difendere le isole dalle onde di tempesta (1740-1782) e delle successive banchine all’interno delle insenature (1808-1927). Più recentemente si è cercato di ricavare quanto più terreno possibile per lo sviluppo urbano e industriale (1927-1960), si è andati incontro a fenomeni di subsidenza (9 centimetri di abbassamento dal 1930 al 1970) legati all’estrazione di acqua dolce e gas naturale e si è cercato di stabilizzare e costruire aree umide artificiali.
In questa breve carrellata non poteva mancare il progetto MOSE, in fase di realizzazione dal 2003: la costruzione di barriere mobili nei pressi dei varchi (le bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia) che collegano la laguna al mare aperto per isolare temporaneamente la città durante gli eventi di alta marea.
Tutti questi interventi hanno impresso segni che possono essere letti attraverso il confronto della cartografia storica con quella attuale. Ora, però, è possibile valutare in maniera quantitativa, più precisa e accurata, l’azione dell’uomo impiegando una nuova tecnica: la mappatura batimetrica multicanale.
La pressione delle attività umane: i danni dell’erosione
La grande mole di dati raccolti ha fornito testimonianze senza precedenti sull’invasività dell’impatto umano, azione che va molto oltre la diminuzione delle dimensioni delle aree umide o le modificazioni artificiali della geometria delle insenature della laguna. Ci sono impronte dirette e indirette: le prime sono quelle in cui l’uomo ha modificato attivamente la morfologia del fondale, nelle seconde l’alterazione è una reazione del sistema delle maree a una perturbazione umana. Sono stati, quindi, osservati dagli scienziati i segni del dragaggio e quelli intorno alle strutture costruite per proteggere la città dalle inondazioni.
Fantina Madricardo, autrice dello studio, ha spiegato: “[…]sono state per la prima volta documentate tracce di dragaggi, solchi incisi dalle chiglie di navi fuori rotta su bassi fondali o dai motori delle barche e dalle eliche dei vaporetti alle fermate, che in condizioni di bassa marea ‘arano’ il fondale. Di grande rilevanza sono le strutture erosive operate dalle correnti di marea attorno alla maggior parte delle infrastrutture costiere realizzate su base subacquea, come i moli detti ‘lunate’ che proteggono le bocche di porto dalle onde marine, dove si sono formate depressioni di alcuni metri nel giro di pochissimi anni successivi alla loro costruzione. Effettuare rilievi ripetuti nei prossimi anni, con gli stessi strumenti utilizzati in questo studio, permetterà di individuare precocemente e, sperabilmente, prevenire eventuali crolli delle dighe stesse”.
La minaccia dei rifiuti
È stata rilevata anche la presenza di rifiuti nei canali lagunari, in misura variabile a seconda delle attività economiche dell’area adiacente al ritrovamento registrato, anch’essi una minaccia per l’equilibrio dell’ambiente. I rifiuti marini alterano la morfologia dei fondali così come il loro habitat: formano un nuovo substrato che può minacciare le antiche strutture classificate come beni archeologici e coprire le comunità biologiche presenti, causando inquinamento chimico e fisico e interferendo con la vita del fondale stesso.
A proposito di questo aspetto della ricerca, Fabio Trincardi, direttore del Dipartimento di scienze del sistema Terra del CNR e ideatore dello studio, ha commentato: “Una sorta di ‘terra dei fuochi’ subacquea in cui un misto di incuria, dolo e inconsapevolezza porta molte persone a credere che quanto si getta in mare non abbia conseguenza sugli ecosistemi e sulla salute umana, solo perché questo ambiente non è immediatamente visibile e ci induce a fingere che il problema non esista. Abbiamo scelto la laguna di Venezia per testare questo approccio allo scopo di far capire che in tutte le aree costiere e nei fondali marini non abbiamo solo il problema dell’inquinamento da sostanze chimiche ma anche quello dei rifiuti solidi, al di là delle plastiche e microplastiche oggetto di una diffusa attenzione, e quello di strutture necessarie come moli e dighe, rispetto alle quali però bisogna tenere conto delle modifiche ai campi di corrente che esse stesse inducono e da cui possono essere messe in pericolo”.
L’Antropocene è l’epoca geologica attuale, caratterizzata dall’impatto dell’uomo sui processi evolutivi del nostro pianeta. Malgrado non abbia ancora ricevuto un riconoscimento effettivo in termini geologico-stratigrafici, anche alla luce della ricerca appena descritta in questa News, è difficile negare la sua esistenza. Ci spiega come combattere l’impatto delle nostre attività Gianfranco Bologna nel suo articolo “Come attuare la sostenibilità nell’Antropocene?”, che potrete acquistare e leggere singolarmente o con l’intero numero di dicembre 2018 di Sapere.
Credits immagine: foto di Free-Photos da Pixabay