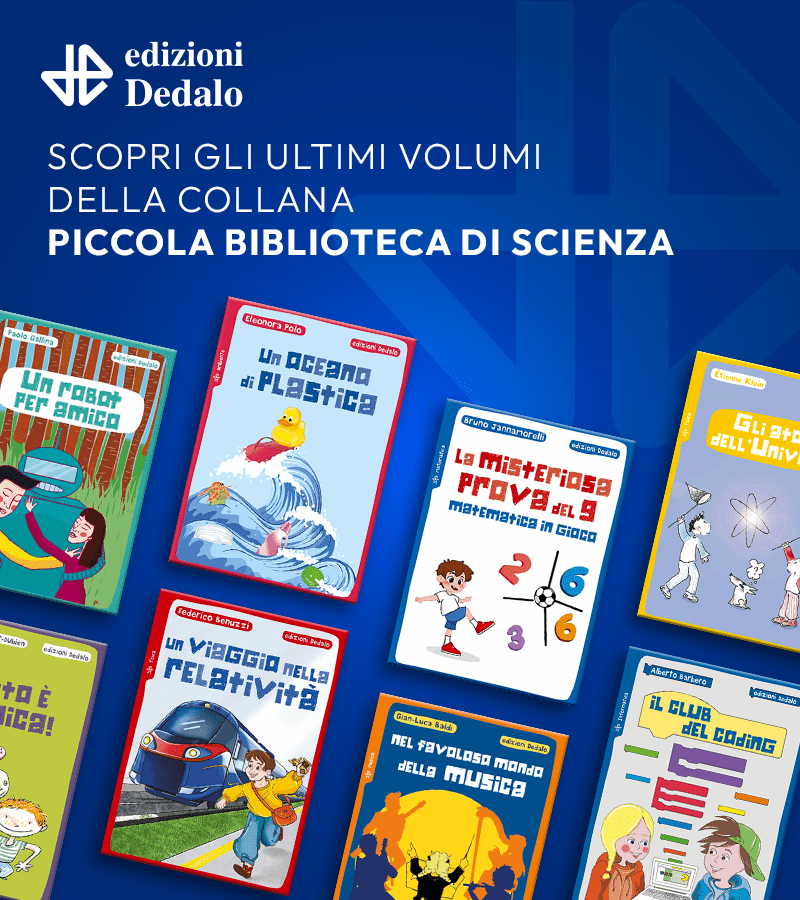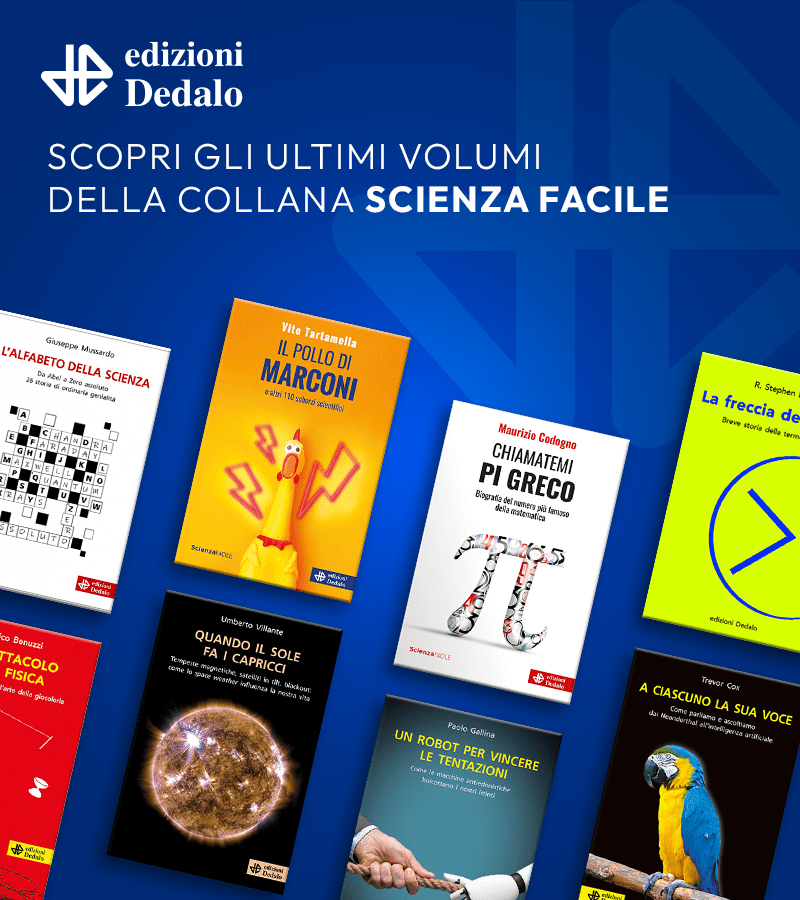Soltanto due secoli fa la struttura dell’atomo non era definita meglio di quanto non fosse tramandato dall’antichità, ossia da Democrito. Per lui, la materia è costituita di particelle indivisibili tutte eguali, variabili in numero e in disposizione nelle diverse sostanze. Solo alla fine dell’Ottocento si comincia a descrivere l’atomo come un sistema complesso, costituito da un insieme di cariche elettriche più e meno, legate tra loro dalla forza di Coulomb, pari in numero, così da garantire neutralità all’atomo.
Soltanto due secoli fa la struttura dell’atomo non era definita meglio di quanto non fosse tramandato dall’antichità, ossia da Democrito. Per lui, la materia è costituita di particelle indivisibili tutte eguali, variabili in numero e in disposizione nelle diverse sostanze. Solo alla fine dell’Ottocento si comincia a descrivere l’atomo come un sistema complesso, costituito da un insieme di cariche elettriche più e meno, legate tra loro dalla forza di Coulomb, pari in numero, così da garantire neutralità all’atomo.
L’inglese J. J. Thomson pensava a una specie di “pasta” carica positivamente in cui si trovano immerse le cariche negative, gli elettroni. Il primo passo verso l’atomo moderno fu compiuto nel 1911 da Ernest Rutherford, il quale lo descrisse come un sistema planetario costituito da un nucleo positivo attorno al quale, nel vuoto, orbitano gli elettroni. Subito un interrogativo: perché gli elettroni non vengono catturati dal nucleo? Essendo elettricamente carichi, orbitando emettono energia elettromagnetica (come aveva da poco dimostrato H. R. Hertz) con una continua perdita di velocità e conseguente discesa a spirale sul nucleo.
La contraddizione fu in parte risolta grazie all’idea rivoluzionaria di Niels Bohr, fisico danese, che solo certi valori del raggio siano possibili. Su tali orbite – ciascuna corrispondente a una data energia (quantizzazione) – gli elettroni si trovano in equilibrio e non irradiano. Oggi la meccanica quantistica ci dice che la nozione di elettrone come corpicciolo in moto orbitale attorno al nucleo va sostituita con quella di probabilità di distribuzione della densità di carica negativa attorno a esso. Inoltre, a convalida di un’assunzione già fatta da Bohr, essi possono scambiare energia con il mondo esterno – ricevendola o cedendola – soltanto se compiono “salti quantici” da un livello di energia a un altro. Le dimensioni tipiche dell’involucro elettronico sono alquanto inferiori al nanometro (miliardesimo di metro). Poiché il nucleo ha un’estensione circa 10.000 volte inferiore, l’atomo è praticamente fatto di vuoto. Noi siamo fatti di vuoto!

Esiste una tecnica che consenta di “fotografare” l’atomo dando così una prova tangibile della sua struttura discreta? Negli anni recenti sono state sviluppate diverse tecniche nanoscopiche – ossia di microscopia su scala del nanometro – che di fatto permettono di visualizzare i singoli atomi. Ciò che si “fotografa” è appunto l’involucro di carica elettronica attorno al nucleo. È una fotografia sui generis, trattandosi in realtà di misure di corrente elettrica, ma grazie alle tecniche di elaborazione delle immagini via computer, si può parlare di vere e proprie “effigi” degli atomi. La tecnica più interessante, tra le varie possibili, è quella che si indica con la sigla STM dall’inglese Scanning Tunneling Microscopy (Microscopia a scansione per effetto tunnel). Una punta metallica viene fatta muovere in prossimità della superficie del materiale in esame, scansionandola riga per riga. Si opera in condizioni di vuoto. La punta, così acuminata da terminare in un singolo atomo, viene tenuta assai vicina alla superficie, carica positivamente, in modo da cedere a essa elettroni per “effetto tunnel”, ossia per transito diretto attraverso l’intercapedine di vuoto. Tale effetto si rende possibile soltanto sulla scala delle distanze interatomiche. Poiché il flusso di corrente elettronica cresce esponenzialmente al diminuire dello spessore dell’intercapedine, la corrente aumenta o diminuisce sensibilmente allorché la punta, nella sua ricognizione, passa sopra gli involucri elettronici degli atomi oppure sopra gli spazi vuoti tra essi. La seconda figura mostra singoli atomi alla superficie di un cristallo di silicio, come vengono descritti dal livello di corrente.
Credits immagine: foto di NakNakNak da Pixabay