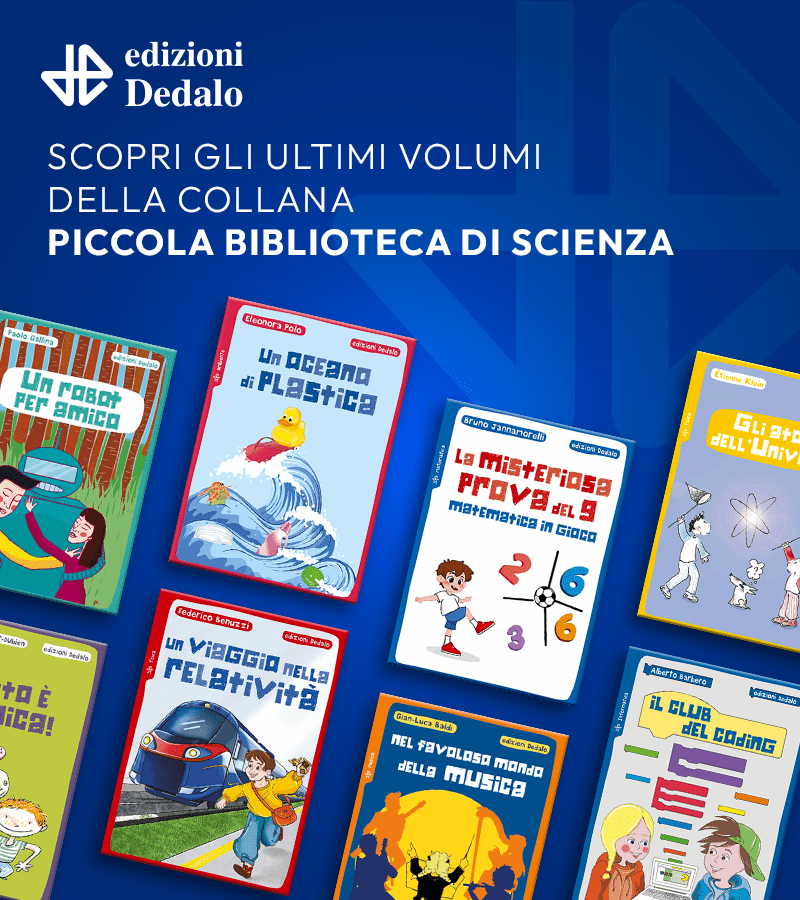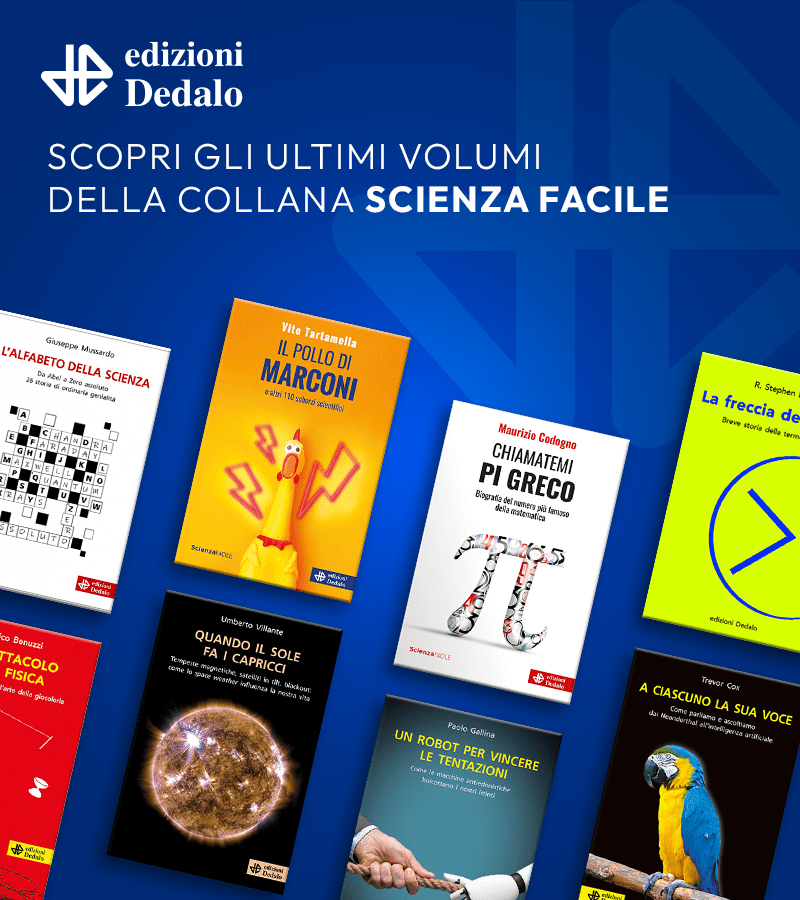Per dimostrare che la Terra ruota, e trovare le leggi che governano il cosmo, sono serviti 2000 anni. L’uomo si è sempre chiesto cos’è l’Universo e, mistero dei misteri, come fa a esistere. In questa breve ricostruzione la storia ci mostra come si è evoluto il pensiero scientifico sulla rotazione della Terra.
Le prime descrizioni del Sistema Solare e della Terra
– Partiamo dai Pitagorici (fine V secolo a.C.), i primi a tentare una descrizione del Sistema Solare in cui la Terra non sta ferma.
– Il modello lasciato da Filolao è il seguente. Ogni pianeta, così come il Sole e la Luna, è fissato alla superficie di una sfera che ruota da Ovest a Est attorno al “Fuoco Centrale”. Questo dalla Terra non si vede perché il lato abitato è oscurato da un’Antiterra. Le stelle fisse stanno tutte su un’unica sfera, la più esterna. Il Sole riversa su di noi la luce che riceve dal Fuoco Centrale.

La Terra gira più velocemente di Sole e Luna, e una volta al giorno li sorpassa con l’effetto apparente di un loro sorgere a Est e un tramontare a Ovest. Come sassi lanciati nell’aria, i corpi celesti emettono un suono e poiché il moto circolare implica armonia, l’Universo è pervaso da una musica celeste, che non udiamo per assuefazione.
– Aristotele (IV sec a.C.) liquida questo quadro, ribadendo che i corpi non si muovono, ma restano fissi sulle loro sfere. L’armonia celeste, per Aristotele, è emblematica di una scienza priva di aderenza alla realtà.
– Aristarco di Samo (310-230 a.C.). Se pensiamo alle secolari dispute circa la teoria eliocentrica di Copernico, sorprende come, già nell’antichità, qualcuno avesse descritto il Sistema Solare nel modo corretto. Aristarco, copernicano ante-litteram, è il primo a parlare di Sole e stelle fisse e a suggerire che la Terra compia un’orbita circolare attorno al Sole.
– Claudio Tolomeo (100-170 d.C.). Oppositore di Aristarco, Tolomeo propone un sistema in cui la Terra, privilegiata, sta al centro dell’Universo e il Sole e i pianeti le girano attorno. Poiché la Bibbia stessa convalida questa visione (Mosè a un certo punto esclama: “Fermati o Sole…”), il goffo sistema tolemaico, dove per spiegare il moto retrogrado dei pianeti occorre introdurre, oltre ai cicli, degli epicicli, sopravvive per millenni.
La rivoluzione copernicana
– Niccolò Copernico (1473-1543). Due millenni più tardi il polacco Copernico rispolvera l’eliocentrismo con il De Revolutionibus del 1543, ipotizzando che la Terra ruoti sul suo asse: malgrado la dedica al Papa, è subito burrasca. La teoria è vista con sospetto persino dagli scienziati. Lutero bolla le idee di Copernico come antibibliche, e la Chiesa cattolica nell’anno 1600 spedisce sul rogo Giordano Bruno, copernicano ostinato.
– Tycho Brahe (1546-1601). Un appiglio per coloro che prendono la Bibbia alla lettera viene dal sistema di Tycho, un compromesso che piace ai Gesuiti. Sole e Luna girano attorno alla Terra, mentre gli altri pianeti ruotano attorno al Sole. Il modello, dovendo reintrodurre gli epicicli di Tolomeo, complica tutto. Ma Tycho afferma che se la Terra viaggiasse su un’orbita, la posizione delle stelle, ciascuna rispetto alle altre, cambierebbe nel corso dell’anno (oggi tale effetto, sebbene piccolo, è visibile e si chiama parallasse stellare).
– Galileo Galilei (1564-1642). Galileo è colui che alla teoria copernicana dà l’impulso maggiore. Rifiutando le verità acquisite dalla tradizione, Galileo cerca inutilmente di convincere la Chiesa che il rifiuto dell’eliocentrismo finirà per nuocerle. Il suo atteggiamento critico lo conduce al processo, culminante nell’abiura a tutti nota. Gli scritti di Galileo rimangono all’Indice fino al 1835! Soltanto con Giovanni Paolo II, la Chiesa abbozza una timida “riabilitazione” dello scienziato.
– Giovanni Keplero (1571-1630). Studente di Tycho a Praga, gli succede nel ruolo di matematico imperiale. Le sue tre leggi (1619) esposte nel trattato Harmonices Mundi mettono un punto fermo alle diatribe sul moto dei pianeti. Il suo contributo è cruciale, benché Galileo stesso lo trascuri, forse perché le orbite ellittiche di Keplero gli sono sgradite.
– Pierre-Simon de Laplace (1749-1827). Il marchese di Laplace è colui che, partendo dal lavoro di Isaac Newton, porta a una comprensione dettagliata delle orbite planetarie, a includere le loro anomalie. A Napoleone, che gli chiede perché nel suo modello non si parla mai di Dio, risponde: «Non ho avuto bisogno di questa ipotesi».
Maggiori dettagli su questa fascinosa vicenda sono raccontati nel mio libro Il Cosmo e il Buondio (2009 BUR Rizzoli).