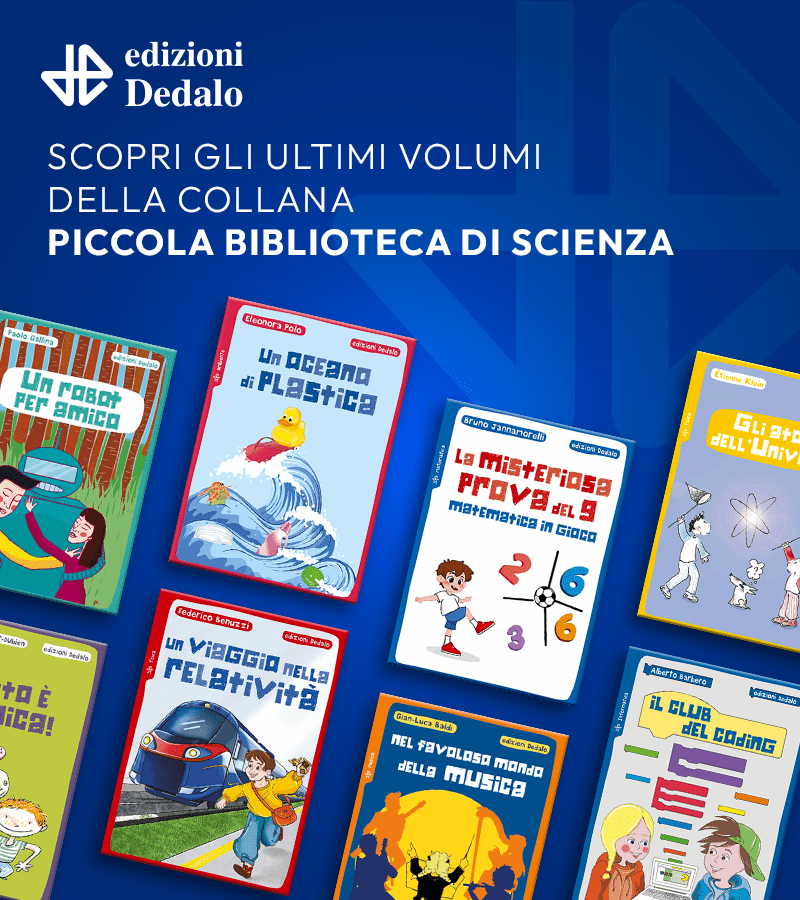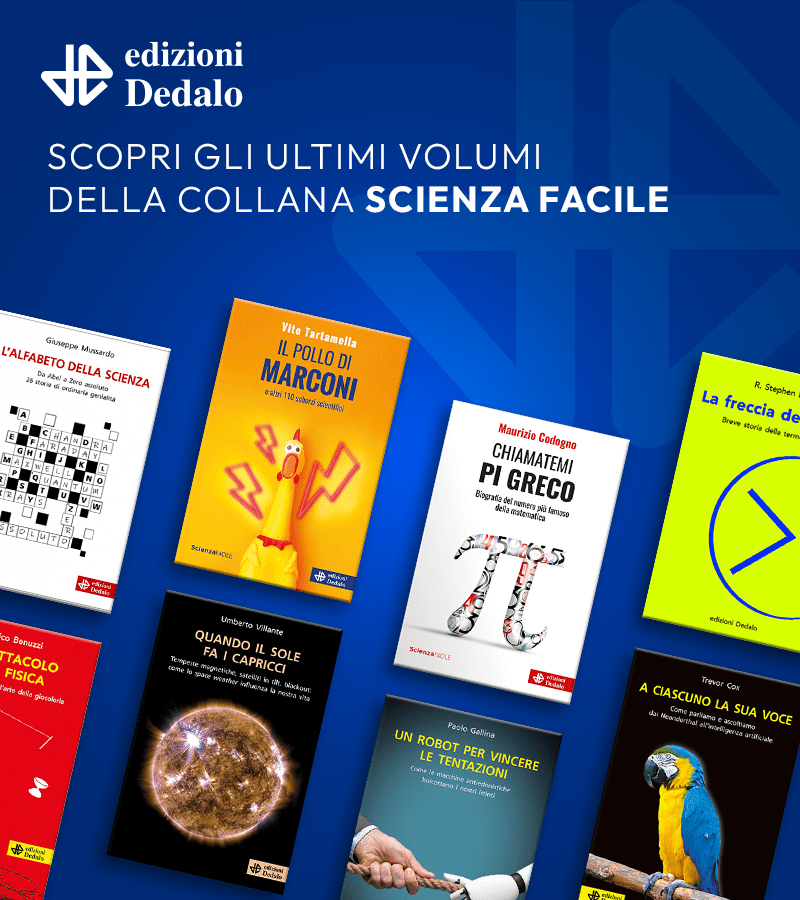Al liceo, la professoressa di Italiano mi suggerì di fare il giornalista. Debbo dire che l’idea non mi dispiaceva, ma poi prevalse l’interesse per la scienza. Quando l’editore mi propose di assumere la direzione di Sapere, si chiuse quasi un cerchio: potevo fare un po’ entrambe le cose. Accettai, senza pensarci troppo.
Sono passati poco più di dieci anni ma, per la carta stampata e la scienza, sembra passato un secolo. Il primo tormentone delle discussioni in redazione fu che non potevamo vendere solo in libreria: per un vero rilancio dovevamo tornare in edicola! Vagheggiavamo i tempi d’oro degli anni ’70-80, quando Sapere vendeva 50 000 copie nei chioschi lungo le strade. Nessuno pensava che, nel giro di pochi anni, le edicole sarebbero state falcidiate da un tracollo di vendite non solo delle riviste, ma pure dei quotidiani. Le prime sono praticamente scomparse anche dalle librerie. È impressionante la velocità con cui quelle nostre discussioni siano diventate giurassiche.
L’informazione oggi
Oggi le persone, soprattutto giovani, pretendono che l’informazione e la conoscenza siano immediate, online e soprattutto gratis. Ovviamente non c’è nulla di gratuito nei contenuti online, altrimenti Google (Alphabet) non capitalizzerebbe in Borsa 2000 miliardi di dollari. Ma è difficile convincere le persone che dietro questa finta macchina gratuita dell’informazione a portata di dito si nascondono spesso sfruttamento del lavoro, superficialità, fake news da social, oligopoli e, ovviamente, commercializzazione della nostra “vita digitale”. Lo stato dell’informazione è un terreno fertile per la “costruzione del racconto”, da sempre strumentale alla raccolta del consenso. Nel giro di pochi mesi abbiamo sdoganato l’idea di entrare in guerra diretta con la Russia e derubricato la “transizione verde” come imposizione di oscuri poteri forti a danno dei più deboli. Se due anni fa ci avessero raccontato che finiva così, non ci avremmo creduto. Forse la qualità dell’informazione avrebbe bisogno di un tagliando.
La “crisi” delle testate scientifiche
Anche le testate scientifiche soffrono di un problema di qualità, ma per ragioni molto diverse. Nell’ultimo decennio il numero degli articoli annuali è aumentato di oltre il 50%: da 2,2 a 3,5 milioni. In parallelo, il numero di riviste è salito a dismisura. Questi dati potrebbero essere interpretati come un’ottima notizia: la scienza scoppia di salute! Purtroppo, non è così.
Come ho già spiegato qui, gli articoli scientifici debbono essere soggetti al processo di revisione tra pari (peer-review) prima di essere pubblicati. È un lavoro (gratuito) che richiede serietà, preparazione e tanto tempo. Nel corso di trent’anni ho revisionato centinaia di articoli, l’ho fatto con dedizione e anche un po’ di orgoglio, perché è il pilastro su cui si regge la credibilità della scienza. Ultimamente, però, non sono più in grado di gestire il flusso in ingresso, in crescita incessante: declino molte richieste. È una situazione diffusa, che causa profonda frustrazione tra gli scienziati. La sperimento anche nel ruolo di editor, cioè quando tocca a me scegliere i revisori dei lavori e prendere la decisione se pubblicare o respingere. Trovare persone che accettino l’incarico è sempre più difficile.
Il colpo di grazia lo ha dato il boom dell’attività scientifica in Paesi immensi come la Cina e l’India, che hanno travolto il sistema. La situazione può assumere anche aspetti comici poiché nomi cinesi diversi, una volta convertiti nell’alfabeto italiano, a noi suonano del tutto simili. Il risultato è che non sai letteralmente a chi stai chiedendo una valutazione. Se a fatica ne trovi uno, spesso rifiuta: sono troppo impegnati a scrivere articoli, mica hanno tempo per valutarli.
In tutto ciò la scienza è in forte sofferenza: è cresciuto l’edificio, ma le colonne portanti si sono indebolite. Siamo travolti da una quantità abnorme di articoli, la cui qualità tende a calare per l’impoverimento della valutazione. Il rischio di una profonda crisi di credibilità è sempre più alto e non è una buona notizia.
Lo so, gli articoli celebrativi sono di solito carichi di fiducia. Ho optato per la sincerità, spero non me ne vogliate.