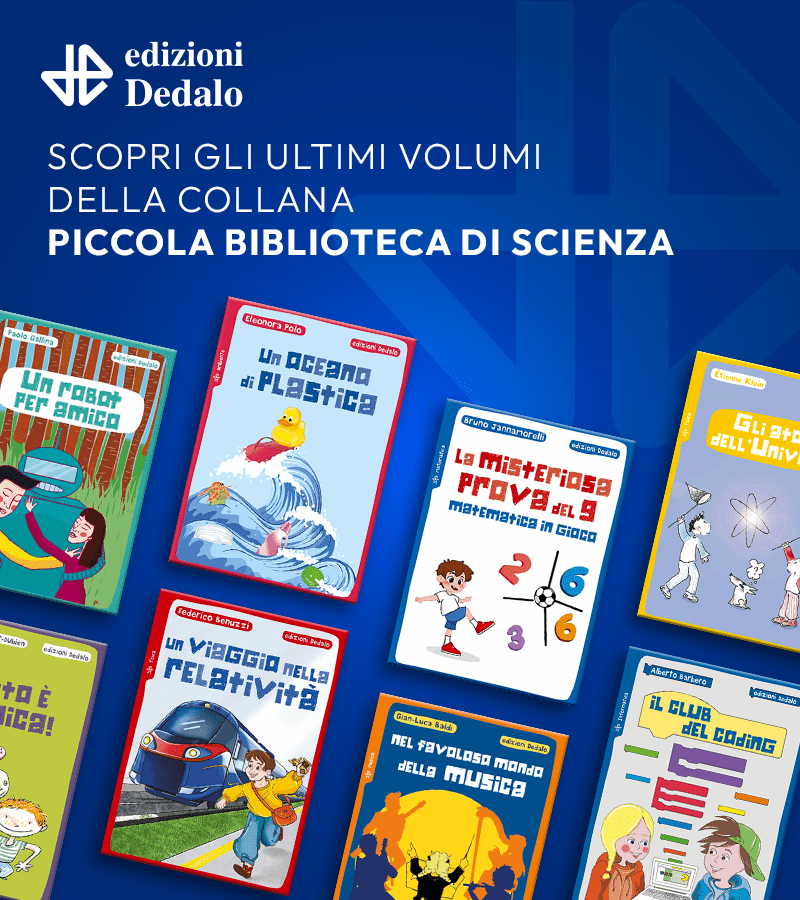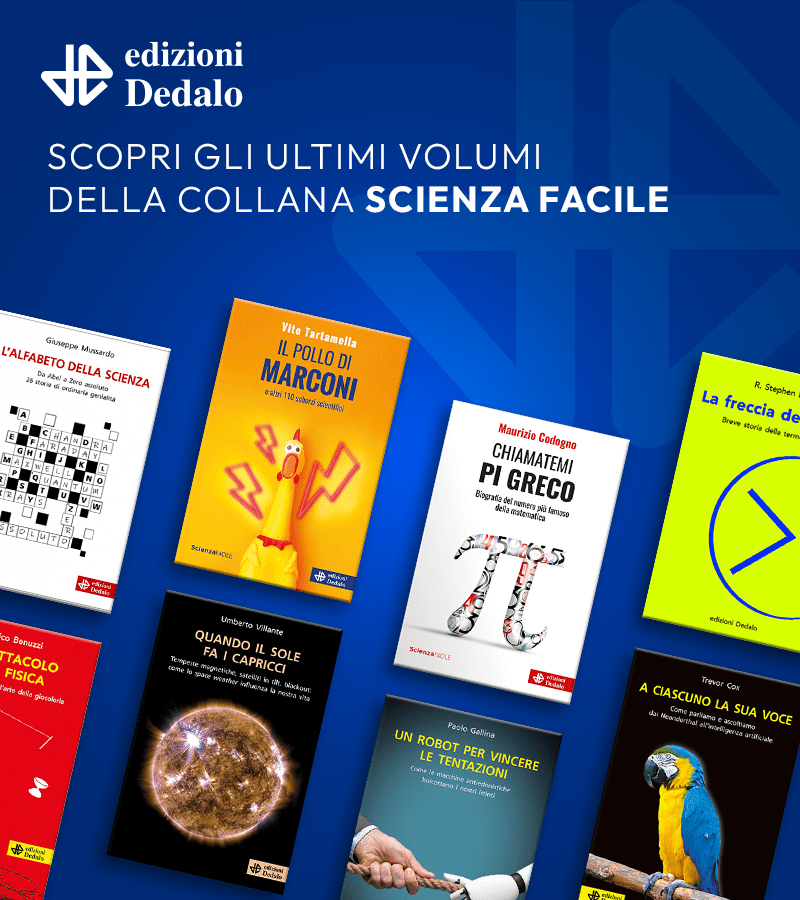Ho appena terminato la lettura di un intreccio profondo tra biografia, condizione sociale afroamericana e storia (recente) della scienza, o meglio di quella scienza chiamata biologia. Parlo del bellissimo La vita immortale di Henrietta Lacks, di Rebecca Skloot.
Sembra che la ricetta per la buona divulgazione scientifica, quella che fa appassionare a un certo argomento, venga, ancora una volta, confermata: il segreto è raccontare una storia, in questo caso di persone, di individui che emergono e stanno sullo sfondo, secondo una partitura e una “regia” nell’intreccio che l’autrice ha saputo orchestrare molto bene. Non vogliamo qui raccontare la trama del libro, se non per accenni, quanto piuttosto soffermarci sulla biografia di Henrietta, ma anche sull’“età dell’innocenza” della scienza, quella degli anni (1951) in cui la protagonista morì di tumore alla cervice uterina al Johns Hopkins Hospital e in cui le cellule, per studiare, per fare ricerca, per far progredire la scienza, venivano donate gratuitamente a chi ne facesse richiesta.
Etica e medicina
Siamo alle prime battute di una disciplina e di un rapporto medico-paziente ancora tutto da costruire. Siamo ai primordi dove, a braccetto dell’innocenza, c’è un enorme vuoto legislativo – accennato nel libro – su questi temi e su quello che oggi sembra normale per qualunque esame medico si faccia, dal più semplice al più complesso: la firma di un consenso informato, una garanzia (che speriamo sia sempre garantita!) che ciò che ci appartiene – fisicamente e moralmente – non sia oggetto di speculazioni. Di questo vuoto legislativo c’è chi, in buona o cattiva fede, ne ha approfittato senza scrupoli e la storia narra come, di fronte ad alcuni (non tutti!) “istruiti” senza scrupoli, emerga invece la probità e la disperazione della povera gente che, qui come altrove, è stata defraudata di qualche fondamentale diritto.
I temi affrontati nel libro
È una bella storia, fatta d’affetto, d’amore, di disperazione, di condizione sociale disagiata, di ghettizzazione dei colored, in un’America spietata, in cui da sempre se non hai i soldi non ti curi, sei considerato un reietto e un condannato senza redenzione, costretto a vivere ai margini di una società che di te non si occupa, se non quando diventi molesto e vieni messo in galera.
È la storia dei passi avanti che la biologia molecolare ha fatto grazie alla linea cellulare che prende il nome dalla protagonista; di un’ignoranza e di una povertà che aprono le porte a una superstizione, a una fede che consola e lenisce comportamenti crudeli, impossibili da comprendere altrimenti. Ma anche di una fiducia minata dai bianchi e delle difficoltà a cui l’autrice stessa è andata incontro per instaurare un rapporto con gli eredi di Henrietta e avere quindi la possibilità di raccontare tutto questo. Marginalmente è anche la storia di un gruppo di persone che muore in modo pressoché sistematico di accidenti cardiovascolari (infarto, ictus), segno della modernità dei tempi e, ancora una volta, dell’estrazione sociale (ricordiamo incidentalmente che la più grande azienda farmaceutica del mondo è statunitense ed è diventata tale grazie al brevetto e alla vendita dell’atorvastatina, in sostanza uno “stura arterie”).
La scienza in questa vicenda c’è, a volte sullo sfondo, a volte in evidenza, a volte comprimaria. In ogni caso questa è una storia che merita di essere conosciuta.