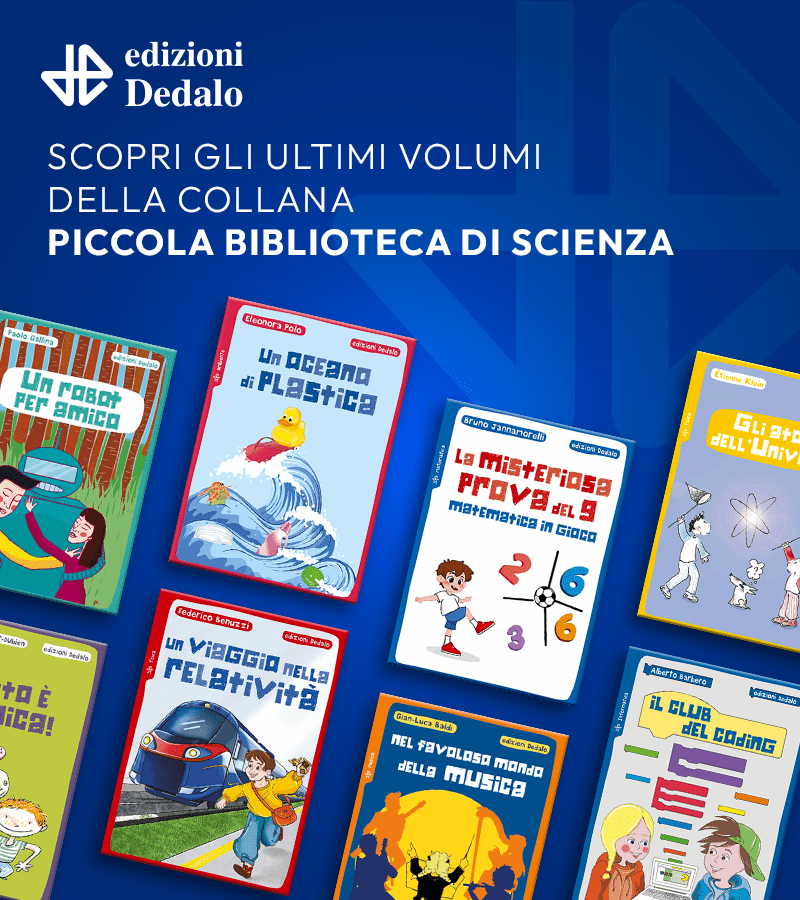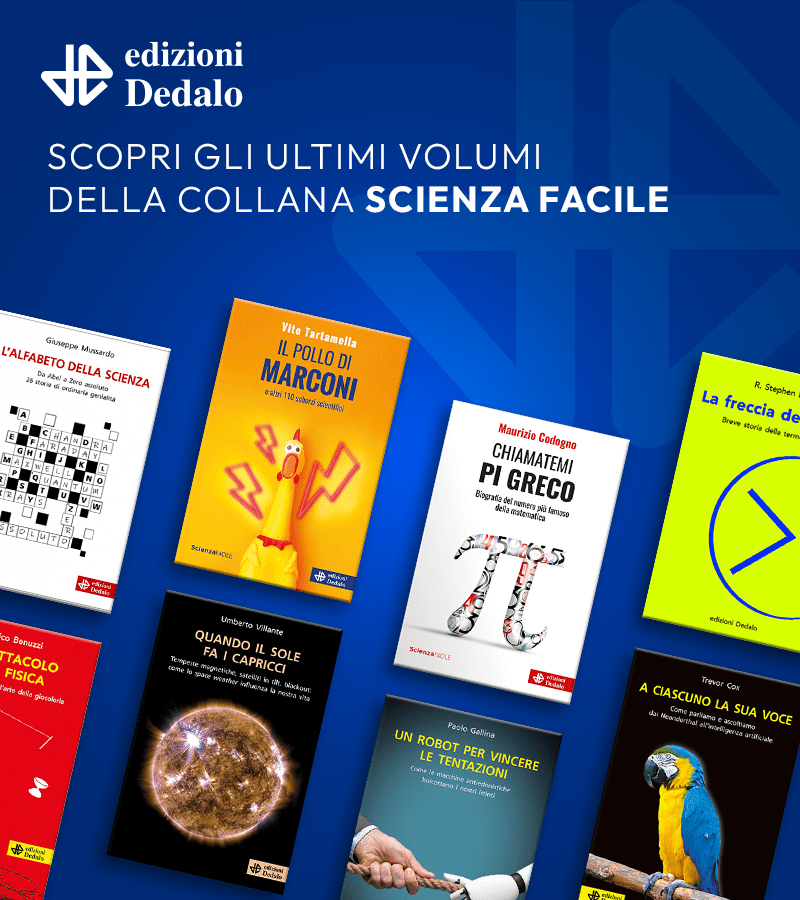Utile, anzi utilissimo ripassare i fondamenti. Siamo abituati a sentirci raccontare – o a raccontare a noi stessi – un po’ sempre le stesse storie, quelle che ci hanno colpito di più, quelle che ci sembra di conoscere meglio, quelle nelle quali ci identifichiamo.
Di cosa parla?
Accade però ogni tanto – e questo è il caso – di imbattersi in altre storie, che magari si conoscono almeno per sommi capi, ma che non abbiamo mai approfondito a sufficienza per capire cosa sostanzia e cosa anima quella parte di mondo che potremmo etichettare piuttosto sommariamente come “ecologista”, un ombrello ormai talmente ampio che rischia di riparare le teste di chi la pensa – in fatto di Natura, della sua salvaguardia, ecc. – in modo diametralmente opposto. E questo è, in sostanza, un motivo che si aggiunge ad altri per leggere tutto d’un fiato oppure a singoli capitoli, che hanno una struttura autonoma, il grande libro di Fabienne Charlotte Vallino Salvaguardare la Natura, rispettare gli Animali, proteggere l’Ambiente, difendere la Terra. I Pionieri del pensiero del nostro tempo, pubblicato dalla casa editrice ETS di Pisa nel 2021.
Titolo lunghissimo per un testo che è una specie di piccola enciclopedia costituita da ben 423 pagine intense e densissime di riferimenti bibliografici utili al lettore per orientarsi nelle storie affascinanti e talvolta tristi (come la parte in cui l’argomento è quello degli animali maltrattati) che in esso sono raccontate.
Uno dei protagonisti del libro: Alexander von Humboldt
Un’opera, insomma, decisamente monumentale, impreziosita da tavole fuori testo a colori, molto belle. È una storia che affonda le proprie radici nella visione romantica della Natura e arbitrariamente – ma di un’arbitrarietà ampiamente giustificata – viene fatta partire con un lungo capitolo iniziale dedicato al naturalista Alexander von Humboldt, che non crediamo abbia bisogno di presentazioni. Mente vulcanica, ebbe una vita affascinantissima, a contatto con le più grandi menti del suo tempo (uno su tutti: Goethe, che ne nutriva grande ammirazione), viaggiando per mezzo mondo (forse potremmo dire intero, considerata l’epoca di tali sposamenti) e raccogliendo osservazioni e dati sul campo che ne fecero uno degli scienziati più influenti del suo tempo e di quelli a venire.
Quel mondo – fatto da pochi sensibilissimi antesignani capaci di scorgere e indicare i pericoli delle attività umane nei confronti di una Natura verso cui già si percepivano le minacce – sembra essere, ai nostri occhi di moderni che vediamo in prospettiva quel pezzo di storia, uno scherzo del destino o quella che chiamiamo “ironia della sorte”.
Von Humboldt nasce infatti il 14 settembre 1769 e, solo pochi mesi prima, nasce anche la macchina che rivoluzionerà la storia, anzi la Storia, ponendosi come base incontrastata del progresso, ma anche come punto iniziale di quella storia della tecnica e della tecnologia che ci ha condotto dritti dritti al punto in cui adesso ci troviamo: la macchina a vapore di James Watt, nota anche come macchina a vapore di Boulton e Watt. Venne sviluppata il 25 aprile 1769 come miglioramento della macchina di Newcomen e diede avvio a quella che tutti conosciamo come Rivoluzione industriale che ebbe luogo in Inghilterra.
Il rapporto tra natura e attività umane
I segni di uno scollamento tra le sempre più intense attività umane e quel che della Natura veniva distrutto, depauperato e perso erano presenti, ovviamente, anche prima di von Humboldt (e ben dopo continuarono): nel 1661 – quasi un secolo prima di quando facciamo partire arbitrariamente questa storia – lo scrittore John Evelyn descrisse una Londra «avvolta in una tale nube da somigliare a un inferno in terra […]. Questo fumo pestilenziale corrode perfino il ferro e rovina tutti i mobili, e lascia una fuliggine su tutto quanto ricopre, e così si impadronisce fatalmente dei polmoni degli abitanti, in modo tale che tosse e consunzione non risparmiano nessuno».
Nel suo libro Evelyn si rivolgeva direttamente a re Carlo II, raccomandando di piantare alberi per ridurre l’inquinamento dell’aria. Nel 1727 il botanico e chimico Stephen Hales dimostrò i collegamenti fra le piante e l’atmosfera nel libro Vegetable Staticks, mostrando che la deforestazione porta a un cambiamento climatico locale. Non è un caso che il nuovo conio che sarà così noto in tutto l’Occidente, “smog”, da qui arrivi come fusione delle due parole “smoke” (fumo) e “fog” (nebbia).
Le attività umane possono ledere gli ecosistemi?
Le preoccupazioni per l’esaurimento delle risorse ittiche e per la perdita delle foreste erano diffuse. Come scrisse uno dei più noti esponenti dell’Illuminismo, Georges-Louis Leclerc, in Les époques de la nature, del 1778: «Pure la condizione la più degna di disprezzo della specie umana non è quella del selvaggio, ma di quelle nazioni a un quarto incivilite, che in ogni tempo furono i veri flagelli dell’umana natura […]. Hanno depredato la terra […] non fanno che affamarla senza fecondarla, distruggere senza edificare, tutto usare senza rinnovar nulla».
Nel 1827, in un manoscritto dal titolo Détérioration matérielle de la planète, il socialista utopico Charles Fourier auspicava una nuova medicina planetaria, analoga a quella per le malattie umane, per affrontare le minacce ambientali planetarie.
E ancora, nel 1876, Friedrich Engels denunciò un problema che, come genere umano, non abbiamo mai affrontato né tanto meno risolto:
In una società in cui i singoli capitalisti producono e scambiano solo per il profitto immediato, possono essere presi in considerazione solo i risultati più vicini, più immediati […]. Prendiamo il caso dei piantatori spagnoli a Cuba, che bruciarono completamente i boschi sui pendii e trovarono nella cenere concime sufficiente per una generazione di piante di caffè altamente remunerative. Cosa importava loro che dopo di ciò le piogge tropicali portassero via l’ormai indifeso humus e lasciassero dietro di sé solo nude rocce? Nell’attuale modo di produzione viene preso prevalentemente in considerazione, sia di fronte alla natura sia di fronte alla società, solo il primo, più palpabile risultato. E poi ci si meraviglia ancora che gli effetti più remoti delle attività rivolte a un dato scopo siano completamente diversi e per lo più portino allo scopo opposto.
Cito direttamente le parole di questi autori perché sembrano scritte oggi. Il dettagliato primo capitolo del libro si inserisce in questo filone, mostrando, per così dire, il lato positivo di questa vicenda, quello della sensibilizzazione e della preoccupazione verso quelle attività umane così impattanti verso gli ecosistemi.
Tutto questo secondo schemi che ci vedono sempre un po’ “fuori dalla Natura”: o come difensori di quest’ultima o come sfruttatori; un po’ vittime insomma di una Natura indomabile, in cui l’Uomo è un’inezia – si ricorda, tra i pittori romantici, se non altro proprio per la magnificenza delle tele, la figura di Ivan Konstantinovič Ajvazovskij e i suoi celebri dipinti di naufraghi in mari immensi e di forza invincibile, come La nona onda, del 1850, oppure semplicemente Onda, del 1889 – e un po’ carnefici, per la nostra notevole capacità di incidere a tal punto sulle dinamiche del pianeta che abitiamo da coniare, come sappiamo, una vera e propria “nuova era”, quella dell’Antropocene. Ma del libro della Vallino questo è solo l’inizio.

Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, La nona onda, 1850 (© Wikimedia).
Gli altri protagonisti del libro
Von Humboldt – divulgatore scientifico ante litteram nel suo tentativo di coniugare sapientemente arte (prevalentemente pittorica) e scienza (naturalistica, legata alle sue stesse scoperte) – lascia spazio ad altre eminenti figure di intellettuali e artisti che si sono adoperati per denunciare lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali soprattutto nel continente americano, con specifico riferimento agli Stati Uniti.
La storia si dipana in sostanza fino ai giorni nostri, con la nascita, intorno agli anni ’60 del secolo scorso, dell’Environmental Movement: il pensiero muta e si arriva alla consapevolezza che l’Uomo non è più (per la verità: non lo è mai stato) “padrone” della Terra e viene messa in discussione la visione della Natura come fonte illimitata di risorse per l’umanità – acquisizione, quest’ultima, che pare non essere ancora del tutto registrata da alcune discipline come l’economia neoclassica.
Le pagine dei capitoli a seguire sono affollate dalle storie di George Perkins Marsh, il cui pensiero influenzò le menti dei presidenti statunitensi Benjamin Harrison e Stephen Grover Cleveland e fu importante punto di riferimento per il Conservation Movement, il movimento politico per la protezione delle risorse naturali (con particolare attenzione verso le foreste), promosso all’inizio del XX secolo dal Presidente Theodore Roosevelt.
Passando per Aldo Leopold si arriva quindi alla poliedrica figura (è citato come: medico, filantropo, musicista e musicologo, teologo, filosofo, biblista, pastore e missionario luterano) di Albert Schweitzer Nobel per la Pace nel 1952, che affronta la delicata questione morale legata al trattamento crudele degli animali – ma il capitolo non si esaurisce con questa trattazione della figura di Schweitzer.
La parte finale
La lunga cavalcata ci conduce ai due capitoli finali in cui è trattata l’“età dell’ecologia” e non può non trattare un’altra pietra angolare dell’ecologismo mondiale, il cui saggio fondamentale, Primavera silenziosa, ha compiuto sessant’anni nel 2022.
Il libro si chiude quindi con il pensiero del filosofo Hans Jonas tra i protagonisti, nella contemporaneità, dell’Uomo che distruggendo la Natura, distrugge in realtà sé stesso, di quell’Uomo la cui potenza tecno-scientifica è tale da condurre sé stesso all’estinzione.
Un testo utile a inquadrare il nostro rapporto da sempre conflittuale con l’ambiente intorno a noi e prezioso per il gran lavoro e le fonti citate.