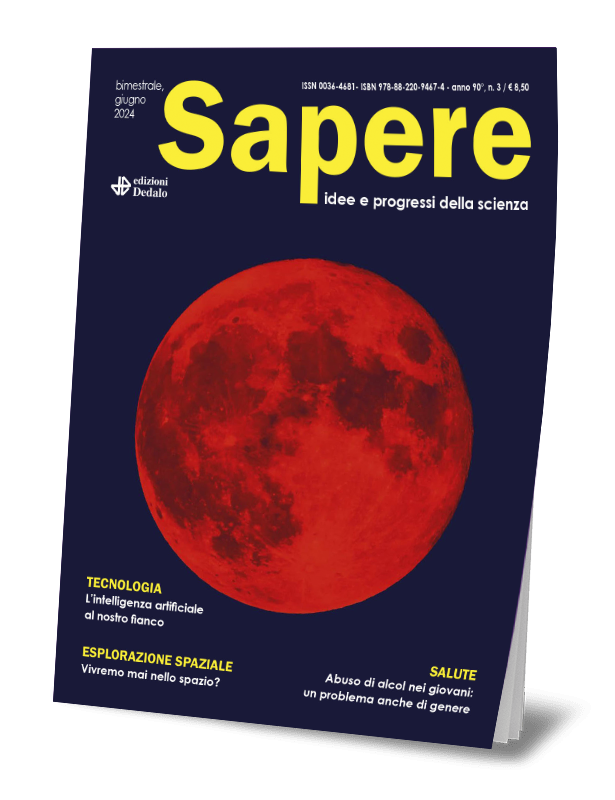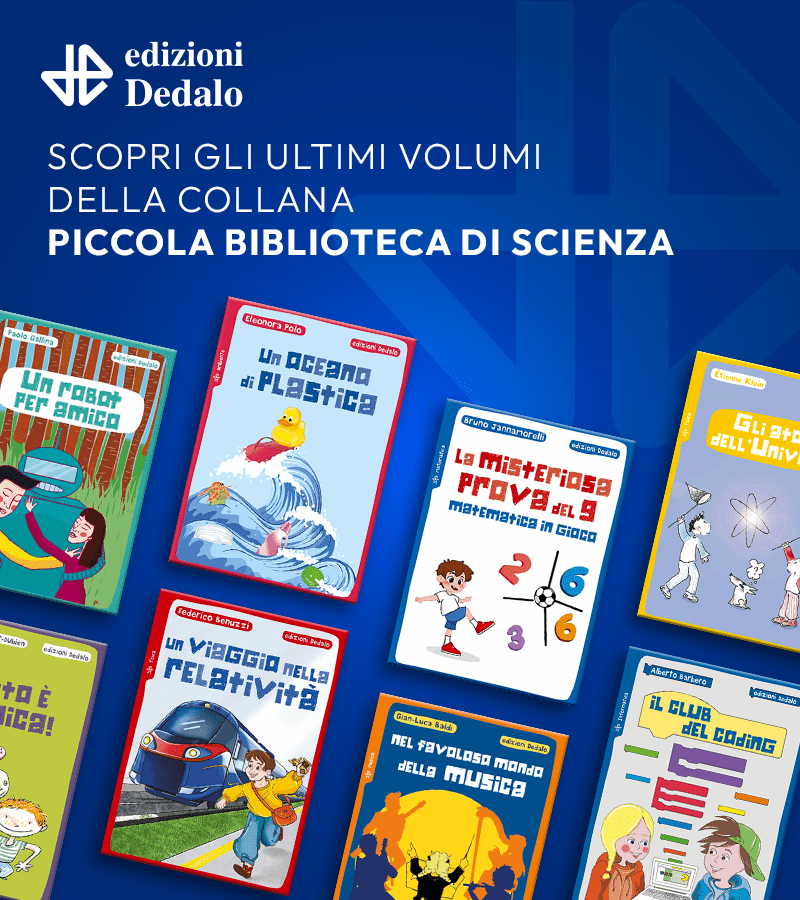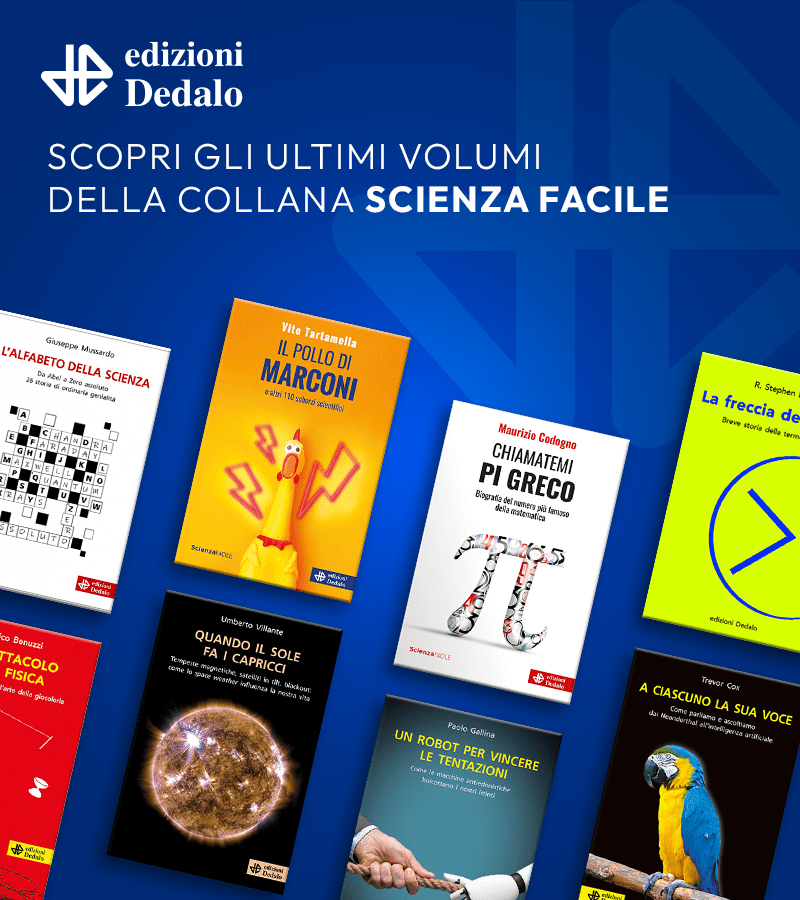Se è vero, come è vero, che la fantascienza – non tutta, ma buona parte – riflette i timori della società nella quale viviamo e rispecchia il suo zeitgeist (come abbiamo visto qui), allora questo primo volume della trilogia Memoria del passato della Terra di Cixin Liu, intitolato Il problema dei tre corpi, lo si può senz’altro annoverare a buon titolo in questo filone.
Innanzitutto è una fantascienza che ha le sue basi in eventi storici realmente accaduti, come la cosiddetta “rivoluzione culturale” che sconvolse la Cina nel decennio 1966-1976, da cui l’autore stesso, da bambino, è stato travolto. Che le radici siano nella realtà lo suggerisce inoltre il titolo della prima parte, che coincide con il titolo della pietra miliare dell’ecologismo: Primavera silenziosa, come il classico di Rachel Carson.
Lo sfruttamento delle risorse
Il tema – sempre così drammaticamente attuale – del rapporto che abbiamo con il nostro pianeta, prende quindi subito piede insieme all’altro argomento, solo apparentemente secondario: la questione delle risorse. Lo sfruttamento delle risorse naturali non rinnovabili di qualunque tipo (petrolio, carbone, minerali, ecc.) passa per un picco prima di calare inesorabilmente.
Non è tanto una teoria quanto piuttosto un’osservazione empirica, il cui primo (e più famoso) investigatore fu Marion King Hubbert, proprio in relazione al petrolio. Richard Heinberg con un libro pubblicato nel 2007 e mai tradotto in italiano, ma dal significativo titolo Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines, ha esteso il concetto a tutto, appunto, e qualcun altro, John Horgan tra i primi, è arrivato a pensare che la stessa dinamica potesse interessare persino le risorse immateriali come… il pensiero in generale (e, in particolare, le scoperte scientifiche).
Un parallelo con la fisica del XX secolo
Insomma il parallelo (nella mia mente) è presto istituito: la fisica di un secolo fa – quella dei pionieri della meccanica quantistica – è come il Texas di inizio Novecento: bastava bucare da qualsiasi parte e ne usciva petrolio. Con la “nuova fisica” accadeva un po’ la stessa cosa, le scoperte si susseguivano a un ritmo incalzante e in una manciata di anni – con tutto lo sconcerto del caso legato al comportamento controintuitivo della materia nella sua scala subatomica – si arrivò a sistematizzare gran parte dei princìpi e delle teorie che sono ormai del tutto familiari a chi ha una formazione scientifica.
Ma cosa c’entra questo con Il problema dei tre corpi? A pagina 55 si legge: «Non ho contatti diretti con Frontiere della Scienza, ma l’organizzazione è famosa nel mondo accademico. Il suo obiettivo principale nasce dal seguente problema: dalla seconda metà del ventesimo secolo, la fisica ha gradualmente perso la brevità e la semplicità delle teorie classiche. I moderni modelli teorici sono diventati sempre più complessi, vaghi e incerti, e anche la verifica sperimentale è divenuta più difficile. Questo è il segno che l’avanguardia della ricerca sta per schiantarsi contro un muro».
Beh, magari contro un muro no, ma i “picchisti” direbbero che siamo di fronte a un acclarato caso di ritorni decrescenti: se, per tornare al nostro parallelo, per estrarre petrolio dallo “Spindletop” in Texas bastavano quattro assi di legno e poco più che un cavaturaccioli, adesso per avere una resa decisamente inferiore abbiamo bisogno di piattaforme come la tristemente famosa “Deepwater Horizon”; se per scoprire la struttura della materia negli anni ’40-50 del secolo scorso bastavano sincrotroni e ciclotroni grandi come tavoli o stanze, adesso per andare più a fondo e sperare di “trovare qualcosa”, abbiamo bisogno dell’LHC.
La fine della scienza?
Ma questo vuol dire che la scienza “è finita” e siamo arrivati al capolinea? Una provocatoria risposta arriva proprio da un vecchio libro di John Horgan, dal programmatico titolo The end of science (tradotto in italiano con lo stesso titolo, La fine della scienza), anche se possiamo stare tranquilli: nella finzione del romanzo di Cixin Liu a portare la scienza a questa impasse sono gli extraterrestri…